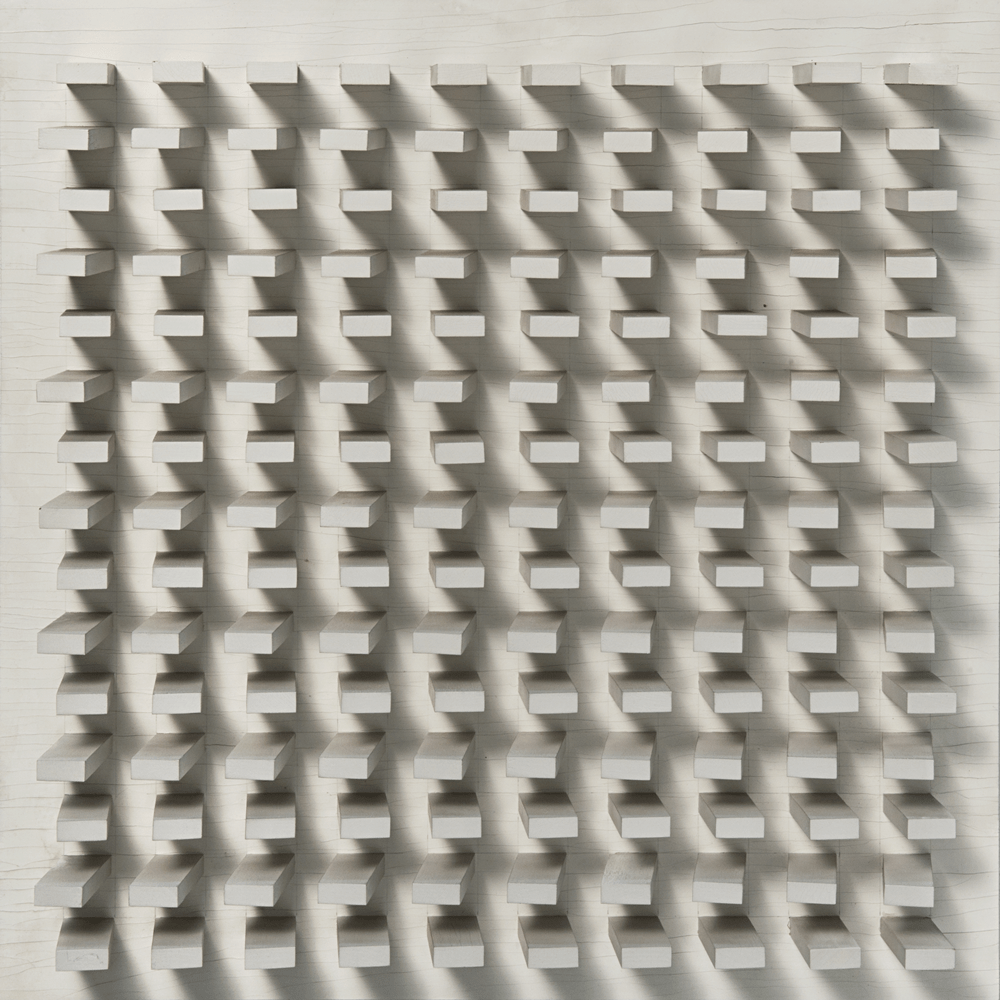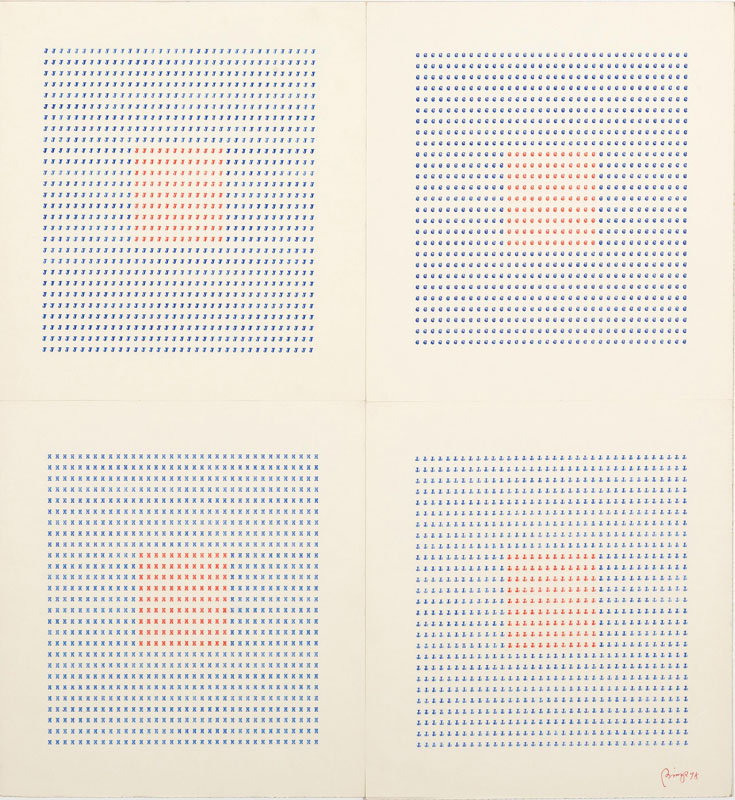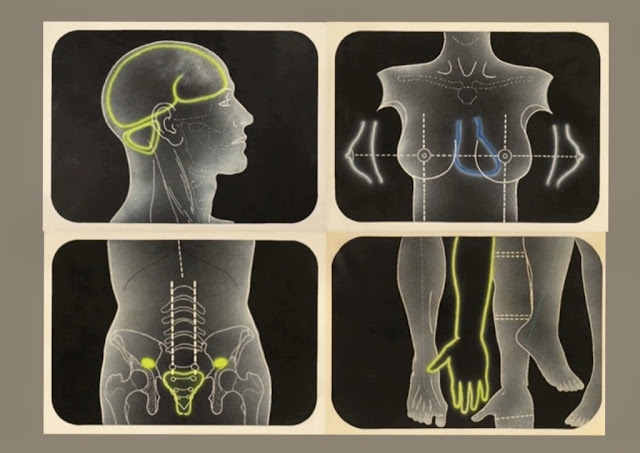Detesto scegliere il gelato. «Creme? Frutta?». Mi guarda. Dietro di me un gruppo di ragazzi aspetta. Alla fine, senza troppa convinzione, indico il cioccolato. «Solo cioccolato?». Mi guarda. «Sì». Gli rispondo. «Solo cioccolato». Superato l’imbarazzo, penso: è finita. Adesso paghi il tuo cono e te ne vai. E invece lui insiste: «Cioccolato gianduia? Cioccolato fondente? Cioccolato all’arancia?». È un incubo, penso. Devo andare via di qui al più presto. E poi, quando sono sul punto di scegliere il fondente, una voce da dietro incalza: «Aò ma te voi sbrigà? Ma quanto ce vole a sceglie er gelato?». Non ho il coraggio di voltarmi. Penso che anch’io al suo posto sarei innervosita da tanta attesa inutile, soprattutto perché lui, a differenza mia, saprà sicuramente cosa scegliere. Anzi, lo sa da prima di entrare, da quando ha sbattuto la porta di casa con l’idea di venire qui. Il gelataio invece non si scompone. Probabilmente non sono né la prima né l’ultima vittima di questa indecisione.
«Prendi er gianduia, è bono. Fidate». Questa volta però a parlare è l’amico. Io non mi ricordo neppure che sapore abbia il gianduia. Non sono neanche sicura di averlo mai assaggiato. Sono sul punto di andarmene, arresa, sconfitta, umiliata. Poi lo vedo. Giallo. Bellissimo. Non so perché non l’avessi notato prima. Mi dico che non presto mai abbastanza attenzione ai gusti che ho davanti. Mi faccio sempre prendere dal panico, precludendomi il piacere di scoprirne dei nuovi.
«Quello cos’è?» Lo chiedo nonostante il nome sia evidentemente scritto accanto al gusto, su un’etichetta ben attaccata alla vetrina. Un modo come un altro, il mio, di temporeggiare.
«Zabaione». Risponde. Penso: sì, lo prendo. Sto per dirglielo. Poi però lui comincia a fissarmi con fare interrogatorio. Forse ha capito che non sono molto convinta, che lo sto scegliendo solo per non fargli perdere la pazienza. Forse lui ha a cuore i suoi clienti e non vuole che esca da qui scontenta. Sarà per questo che senza alcun preavviso mi domanda: «Lo vuoi assaggiare?». Mi rendo conto che non avevo pensato neanche lontanamente a questa possibilità.
La prima tentazione è quella di cedere. Magari così sarà più facile decidersi. Poi però sento la pressione dei due tipi alle mie spalle. Non so neppure che faccia abbiano. All’improvviso però non parlano più. Forse si sono arresi. Forse sono addirittura usciti e io non me ne sono accorta. E se qui dentro fossimo rimasti solo noi due? Penso che dovrei proprio assaggiare lo zabaione. Sì. È inutile rimandare. Mi tormenta però l’idea che possa non piacermi e che a quel punto, dopo averlo assaggiato, non abbia più il diritto di scegliere altro e che tutte le possibilità che ho davanti vengano di colpo annullate. È un pensiero tremendo, che mi spingerebbe a dire subito: «No, grazie». Qualcosa però mi frena. Un ricordo. Quello di mia nonna che energicamente sbatteva le uova fresche insieme a quantità smisurate di zucchero. Improvvisamente si fa strada in me il desiderio di riprovare quel sapore antico ancora una volta.
Sono sul punto di dirgli di sì ma poi mi assale un forte senso di vergogna. Non voglio che uno sconosciuto mi guardi mentre assaporo il gusto del gelato. Quel momento è privato. È mio. Non può rubarmelo. Lui sospira. Non l’aveva mai fatto in tutto questo tempo. Forse non è vero che è così paziente. Forse sta per mandarmi via. Siamo a un punto di rottura. Lo sento. Devo fare qualcosa prima che sia troppo tardi. Non voglio uscire da qui a mani vuote. Lui continua a tenere in una mano il cono vuoto. Ho l’impressione che lo stia stringendo sempre più forte. Temo che potrebbe romperlo da un momento all’altro. Alla fine mi arrendo. Lo guardo ancora una volta prima che lui possa aggiungere o dire qualsiasi cosa.
Zabaione sia. Penso: è andata. Sono salva. Adesso esco da qui finalmente libera e attraverso la strada con il mio cono di zabaione tra le mani e nessuno ma proprio nessuno potrà dirmi niente. Poi però lo sento di nuovo, come una cicala che dopo essere stata a lungo in silenzio riprende con forza il suo canto: «Cioè, famme capì, un’ora pe sceglie il gelato e poi te prenni un cono de zabaione? Ma tutto bene ragazzì?».
Il gelataio mi guarda ancora. Dal suo sguardo capisco che dà ragione al ragazzo dietro di me, di cui ancora non conosco la faccia. Finisco per dargli ragione anch’io ma a lui non lo dico. Non posso. Resto in silenzio. Il gelataio, anche senza il mio consenso, sta per affondare la paletta nello zabaione. Devo impedirglielo. So già che quel gusto non eguaglierà mai il ricordo del sapore che ho in testa. Anzi, al contrario lo rovinerà e io mi maledirò sempre per averlo scelto perché quel gusto cancellerà l’altro, che invece è ancora intatto, vivo.
Sono ancora in tempo ma non ho il coraggio di fermarlo. Penso che i ragazzi alle mie spalle a quel punto mi attaccheranno. Sembrano così aggressivi, anche se ancora non li ho visti in faccia, che potrebbero spintonarmi o peggio ancora lanciarmi addosso il gelato, quello che non ho ancora preso. Sto per arrendermi. Ma poi trovo la forza di fermarlo.
«No, lo zabaione no». Silenzio. Nessuno, me compresa, ha più il coraggio di parlare. Il gelataio si ferma di scatto, come un uomo di fronte a una voragine. Ha capito anche lui che ormai, arrivati a questo punto, non può più farlo. «Amarena, prendo l’amarena». È il gusto di gelato che detesto da sempre. Quando ero bambina credevo che le persone che sceglievano l’amarena fossero cattive. «Mi dia un cono di amarena». Ripeto. Ora che ho deciso voglio che lo sappiano tutti. Il gelataio affonda finalmente la paletta, soddisfatto. Sembra provare un piacere immenso. È finita, mi dico. Adesso mi giro. Voglio proprio vedere che faccia ha l’impazienza. Un attimo prima di afferrare il cono mi guardo indietro. Il tempo di scoprire che i ragazzi non ci sono più.
Foto di copertina di Vivian Maier