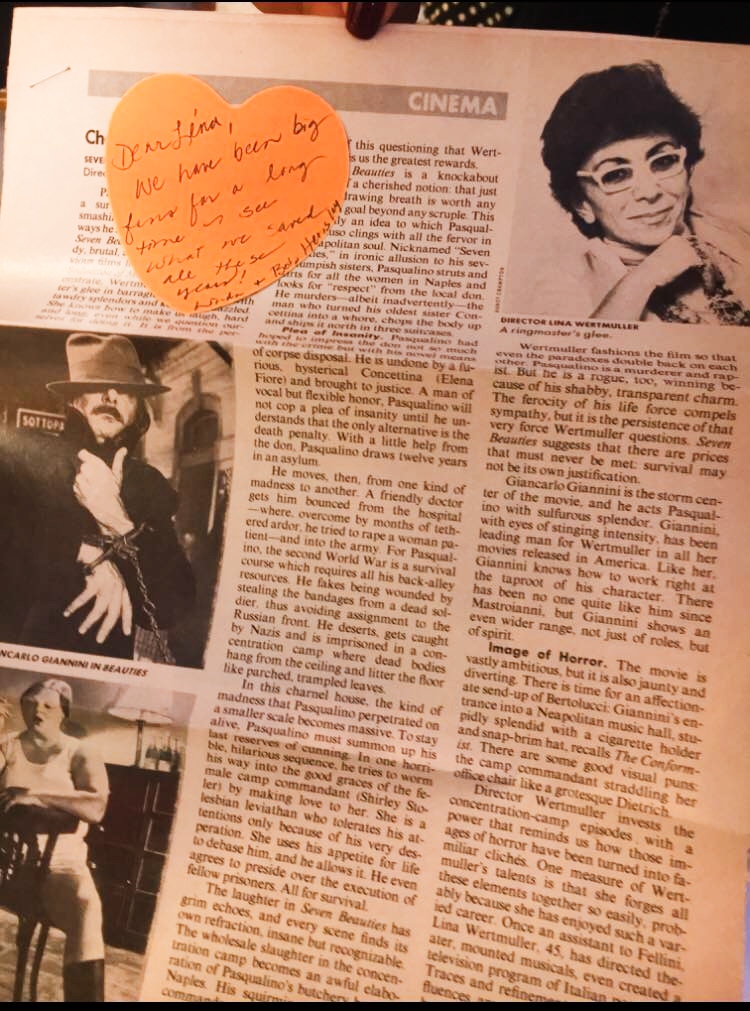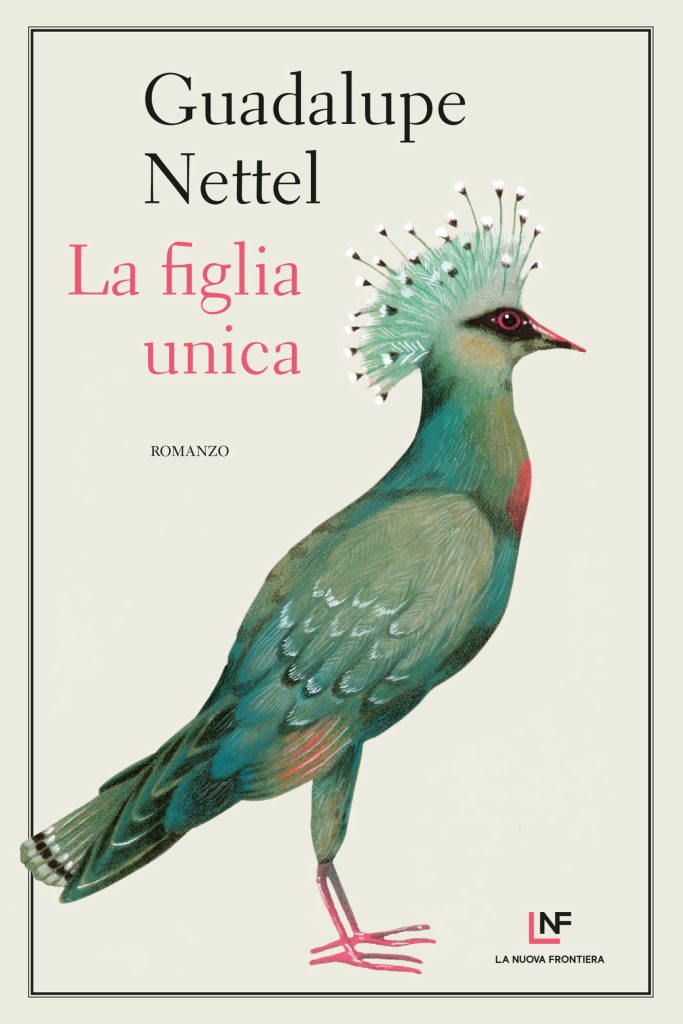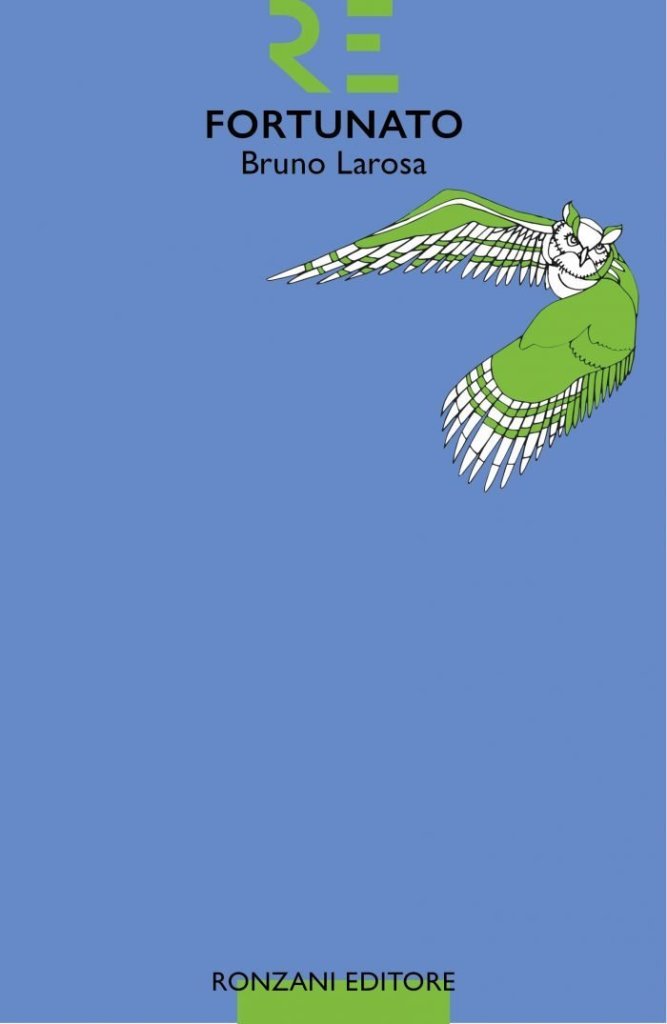Il debutto è avvenuto lunedì 27 alle 20 al Teatro Argentina: Silvio Orlando ha portato in scena la sua interpretazione, meravigliosa, di Momò, cioè Mohammed, orfano affidato da sempre a Madame Rosa – appesantita maîtresse che sta di casa a Belleville al sesto piano di un palazzo senza ascensore. È l’azione scenica tratta da La vie devant soi di Roman Gary, noto compagno di Jean Seberg e noto inquilino di Marguerite Duras in una viuzza interna al Boulevard Saint Germain sul limitare tra il settimo e il sesto arrondissement di Parigi, e poi maestoso occupante di una sua tana in Rue du Bac. Romain Gary, soprattutto noto e grande scrittore dalle molte vite e dalle molte identità, un uomo nella cui esistenza è passata l’intera gamma di una certa transitorietà da est a ovest che ha investito l’Europa per tutta la prima parte del Novecento con le sue storie di esuli e transfughi di cui a un certo punto e a lungo Parigi è stata piena.

Romain Gary era nato Roman Kacew a Vilnius (russa poi polacca infine lituana) nel 1914, figlio di artisti presto divisi: orfano di fatto di padre e dominato dalla madre che voleva realizzare in lui tutto ciò in cui lei era rimasta frustrata. Roman, giovane uomo, approda a Parigi in veste di diplomatico e diventa uno scrittore clandestino: da Roman a Romain il passaggio è breve e intenso. Sappiamo tutto della sua avventurosa e fulgida avventura di scrittore mimetizzato, premiato da grandi riconoscimenti. Molto sappiamo del suo physique du rôle, acclarato dai numerosi fotoritratti in primo piano in cui gli occhi verdi, nel dominante bianco e nero, assumono vertiginosa profondità nelle iridi trasparenti, e spiccano le linee pulite del disegno nel suo volto orientale.
I romanzi grandi di questo autore nascosto ed esploso dietro molti noms de plume, tra cui i più noti sono Romain Gary e Émile Ajar, sono molti, ma, in questo caso, della riduzione scenica, come dicevo, di uno solo vogliamo parlare: Silvio Orlando, forse anche per ragioni personali, per identificazione con l’orfano protagonista, in un’ora e mezza di racconto accorato e stralunato, dà voce a Mohammed da tutti chiamato Momò con l’accento sulla O.

Momò è un bambino dell’apparente età di dieci anni. Per la prima volta a 7 anni ha scoperto che lui, come gli altri sei bambini ospitati da Madame Rosa al sesto piano del palazzo di Belleville che è il loro impervio riparo dal mondo esterno, è mantenuto da vaglia misteriosi e più o meno periodici che coprono le spese di questa sua speciale forma di affido. Momò è un piccolo grande uomo. Ama e odia il suo strano mondo benché non possa non scorgervi gli estremi di una condizione che definisce “infanzia schifa”: ecco che Romain Gary incorpora James David Salinger, e Momò decenne in realtà attestato sui 14 anni ingloba Holden Caulfield che viaggia tra i suoi 16 e 17 anni. Momò è in effetti stregato in modo strano, cioè controverso e contraddittorio, da quel mondo ambiguo di lustrini e tristezza che è il circo coi lazzi dei pagliacci.
Non sto qui a riassumervi l’intera vicenda perché sarebbe assurdo.
Chi ha letto il romanzo sa già qual è la parabola esistenziale di Mohammed detto Momò, e conosce, oltre a Madame Rosa, altre figure che popolano il piccolo mondo indefinito di Momo: Madame Lola, il dottor Katz, Moïse il fratellino ebreo col quale a un certo punto Momò, musulmano, potrebbe finire scambiato – tutto l’entourage è ebraico, e incombe un curioso ritratto di Hitler che ogni tanto Momò tira fuori e mette sotto il naso di Madame Rosa quando vuole davvero scuoterla e rianimarla contando sulla sua reazione atterrita: così emerge anche il racconto del Vélodrome d’Hiver di Parigi dove il 16 luglio del 1942 più di tredicimila ebrei furono radunati dalla polizia francese per essere poi avviati dai nazisti occupanti ai campi di concentramento – Madame Rosa era una scampata della tragica retata.
Chi non lo abbia letto e dovesse accostarsi direttamente alla pièce ricavata dal romanzo da Silvio Orlando scoprirà che il punto chiave sta in qualcosa che accade a partire dalla fine della prima delle tre parti in cui la pièce è suddivisa: a marcare la divisione fra le tre frazioni del racconto reso in prima persona da Momò/Orlando gli intermezzi musicali che cuciono una vera e propria colonna sonora grazie alla presenza in scena dell’Ensemble dell’Orchestra Terra Madre: Simone Campa, direzione, chitarra e percussioni; Gianni Denitto, clarinetto e sax; Maurizio Pala, fisarmonica; Kaw Sissoko, kora e djambe. Molto divertente e significativa a un certo punto l’irruzione proprio di Kaw Sissoko, che dialoga o crede di farlo con Momò parlandogli nella sua lingua africana: come sempre toccante la scanzonata disponibilità di Momò, che non ha capito un’acca ma non ci fa caso, o meglio intuisce nel tono il senso umano di quel discorso, lui che è abituato al caleidoscopio-Belleville, quartiere multietnico dove convivere alla rinfusa è un esperimento pluridecennale cui la gente ha fatto il callo ed è in fondo in grande la forma di coabitazione aperta che già in piccolo si svolge nella casa dove vive Momò – cioè presso Madame Rosa, su su in cima a sei rampe doppie di scale che per la maîtresse-affidataria dal cuore grande, senza ascensore, sono ormai, coi gran chili che si porta addosso, una barriera architettonica.
Cosa accade dunque, ed è poi, per usare un termine dantesco, puntualmente rinterzato?
Accade questo: Momò vorrebbe sparire e farsi notare allo stesso tempo, fa delle marachelle per essere “visto” e puntualmente si ritrova perdonato e coccolato perché è “tanto carino”, è uno che conquista i favori delle donne, e dopotutto è una donna che lui sotto sotto cerca, sua madre; attira ad esempio, un giorno che irrefrenabilmente piagnucola in strada, la simpatia di una ragazza carina, soprattutto molto bionda, molto “giusta”: è Nadine. Seguendola si ritrova in un posto dove avviene qualcosa di rivelatorio, che gli suggerisce un possibile escamotage e il senso profondo dell’esistenza, o meglio del suo irrimediabile fallimento: Nadine lo trascina in una sala di doppiaggio (siamo nel 1970, nella pluri-cinematografica Parigi) e qui Momò scopre che i fotogrammi di una vita, per quanto di finzione come è del cinema, posso essere mandati indietro, i palazzi demoliti possono ricostruirsi, i gesti falliti possono essere ripetuti e aggiustati, i fallimenti possono essere rimediati.
Dunque non c’è solo, come sperimentiamo nelle nostre vite, un andamento lineare della freccia del tempo che va dalla A alla Z. Esiste anche il riavvolgimento del nastro. Esiste il sogno che ciò sia possibile. Esiste il miraggio di un re-inizio: facciamo macchina indietro e ripartiamo, chissà che la vita non si irradi su altre piste. È un’illusione però anche un sogno, una speranza, punto di partenza dell’immaginazione. E allora si staglia in modo diverso davanti ai nostri occhi la sagoma di palazzo che sta al fondo della scena (realizzata da Roberto Crea, illuminata da Valerio Peroni, mentre i costumi di scena sono di Piera Mura) che è come un castello di carta di cui si intravedono gli scalini a simbolo delle scale infinite da salire e scendere, per Madame Rosa e per chi deve sospingerla su e giù una stratosferica difficoltà.

Ecco, quel palazzo diventa man mano sotto i nostri occhi un saliscendi, l’esemplificazione del nostro destino di Sisifi felici. Sta lì a dirci anche che ogni percorso può, a volte deve, esser fatto perlomeno in due versi opposti: si può andare avanti a oltranza e rifarsi anche tutto il tragitto indietro. A questo punto, anche il titolo, La vita davanti a sé, assume qualche altra sfumatura di significato. Ora siamo consapevoli che tutto ciò che ci aspetta, e ci spetta in termini di destino, non è solo unidirezionale. Sappiamo grazie a Momò che quanto ci attende e imboccheremo per forza, spinti da dietro dal tempo che corre avanti, lo percorreremo carichi di quanto già ci ha segnati: è come se ogni volta dovessimo rifare indietro un pezzo della strada già fatta e prendere la rincorsa per poterci lanciare più avanti. Riavvolgere il nastro e rifare un po’ di strada è il nostro naturale passo del gambero.
C’è sempre un passato che torna a riafferrarci, del resto.
A Momò questo accade. Lui che cerca sua madre per pochi istanti ritrova un padre. Uomo spregevole e patetico, come forse potrà esser stato il padre assente di Roman Kacew / Romain Gary / Èmile Ajar, perlomeno filtrato nei discorsi astiosi di sua madre, e poi idealizzato o meglio ricreato dallo scrittore. Momò non è dunque l’eterno decenne, è un molto probabile quattordicenne, anche lui come i suoi fratellini un incidente di percorso nella “carriera” di prostituta di sua madre, affidato con gli altri a Madame Rosa, una specie di grande grossa matrona pachidermica che tuttavia per loro è il mondo intero, è la vita, ed è una casa., altrimenti sarebbero per strada. Tutto ciò che ci accade ci si rivela a un certo punto: emerge dal suo connaturale caos indistinto e comincia a prendere una forma e un principio di significato. Ed è solo l’inizio, è l’asola, o la cruna d’ago, da cui passa il senso intero, e sta a noi provare a tirare la guglia di filo, seguirlo e riavvolgere il verso, soprattutto coglierne lo sviluppo e finalmente intravederne la sagoma.
Come sempre mi accade, anche stavolta ho ripensato a una storia straordinaria che ho letto per la prima volta nel 1992: Dialogo delle ceneri di George Steiner. In termini di consapevolezza, o meglio di ricostruzione del senso delle cose, cioè dell’impronta di destino, si tratta di un racconto magistrale – le voci che dialogano intrattengono discussioni sulle sacre scritture, affrontano cavilli teologici, soppesano passaggi nodali nelle numerose storie esemplari racchiuse nella Bibbia. Chi sono quelle voci? A chi sono appartenute? Leggetelo se vi è possibile e mi direte se il racconto di Steiner non abbia attinenze col vero cuore di ciò che così magistralmente Silvio Orlando ha cavato, e agito sulla scena, da La vie devant soi di Romain Gary.
Effettivamente tornare indietro per un pezzo e provare a riprendere la marcia (per usare le parole di Samuel Beckett, un altro grande: dopo aver fallito, fallire ancora fallendo meglio) forse si può solo se sussiste la vita. Tolta quella, sparisce il campo di gioco, e anche i giocatori, soprattutto loro. Il 1970 è l’anno attuale di questa storia, poi il 1979 è l’anno della sparizione per pillole ed alcol di Jean Seberg, compagna giovane di Gary, che a sua volta si sparerà il 2 dicembre 1980.
La fine di tutto incombe su questa vicenda più di quanto si voglia ammettere, e a questo titolo, La vita davanti a sé, fanno eco le parole affidate da Gary a Radio Canada poco tempo prima di togliersi la vita: «Penso di non avere abbastanza vita davanti a me per scrivere un’altra autobiografia». Ciò che vale qui è la strenua lotta (certo soffusa di dolore) per avere ragione della forte tentazione di mollare: Momò è un ragazzino che a dispetto dei molti sprazzi di avvilimento e forzata maturità mantiene un suo punto critico, direi d’onore, rispetto alla propria vita. Ciò che lo sorregge, e fa di lui un individuo forte, e robusto all’occorrenza, è la volontà di giocarsi la sua partita con le doti e le occasioni che ha. Lottare e andare avanti, e voler bene. Queste le parole finali pronunciate da Silvio Orlando/Momò mentre cala il buio: “Bisogna voler bene”.