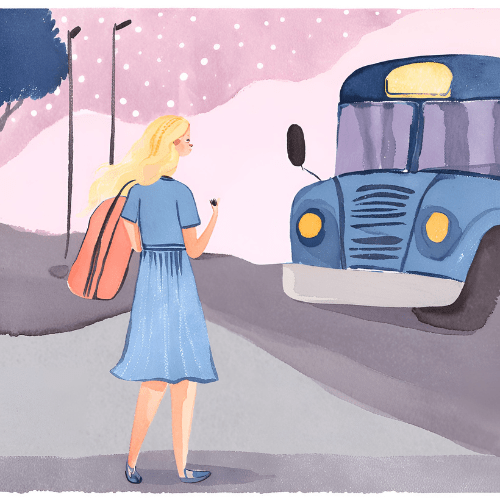Ci sono persone che da sempre detestano la domenica. Persone che se potessero la cancellerebbero direttamente dal calendario. Così, di colpo, via. Che poi, se davvero riuscissero in questa impresa, finirebbero per trasformare anche il sabato, che prenderebbe il suo posto, nel giorno peggiore della settimana. Perché è questo che non sopportano quelli che odiano la domenica: il suo precedere l’inizio, il suo essere sulla soglia, il suo scivolare lentamente e pigramente nel lunedì, costringendoci così a ricominciare sempre, anche quando non ci sentiamo affatto pronti.
La domenica, sentinella davanti alla porta degli impegni e delle responsabilità, conserva anche in sé tutti gli umori e le sensazioni dei giorni che la precedono, come quella sedia su cui svogliatamente appoggiamo i vestiti fino a farla scomparire. La domenica sei costretto a metterli a posto, a riporli nell’armadio. E così anche i ricordi. Perché riaffiorano di più, come se ogni domenica contenesse in sé tutte le altre, quelle che l’hanno preceduta, quelle che ormai non ci appartengono più. È per questo che ci si appiglia con così tanta forza alla malinconia. Nell’infanzia quel giorno significava solo una cosa: tornare a scuola. Chissà se un po’ di quella sensazione si annida ancora in noi, se è precisamente ancora a quella che la nostra mente si riconnette ogni volta che questo giorno inesorabilmente arriva.
Da qui l’idea e il titolo del quinto e ultimo appuntamento di Ghost Track, che si è tenuto naturalmente – senza neanche dirlo – di domenica e più precisamente l’ultima domenica di ottobre, al Mattatoio, all’interno della Galleria delle Vasche della Pelanda. Ghost Track è un progetto del Romaeuropa Festival dedicato ai nuovi formati della parola e della scena, uno spazio in cui prendono forma insieme elementi di comicità, poesia e diverse incursioni musicali.
Protagonista di tutti gli appuntamenti è stata Gioia Salvatori, attrice e autrice che accoglie gli spettatori nello spazio intimo della Pelanda come fossero ospiti che sono venuti a trovarla a casa, tanto che a chi arriva viene offerto anche del buon vino rosso perché – come dice l’autrice – il mondo pesa. Soprattutto la domenica. E i suoi pezzi comici e la sua energia, proprio come il buon vino, hanno il potere di alleggerire e farci ridere di situazioni che noi tutti almeno una volta, a modo nostro, abbiamo vissuto. E questo modo autentico e spregiudicato di raccontare di sé, delle proprie relazioni amorose, dei propri fallimenti, sapendo cogliere anche nei momenti più difficili – come quello della rottura – l’aspetto paradossale, assurdo, ridicolo e naturalmente comico, è puramente catartico. E proprio all’interno di questa dimensione autobiografica che diverte e contagia, si sono inseriti ma senza litigare gli ospiti della serata: Giovanni Truppi e l’attore Daniele Parisi. Truppi ha regalato al pubblico due brani: L’uomo buono muore e naturalmente Domenica, contenuta nell’album Il mondo è come te lo metti in testa. Poi, in modo assolutamente pacifico, si è lasciato intervistare da Gioia Salvatori.

Truppi è il cantautore che nella nostalgia non ha paura di affondare ma che, anzi, attraverso la sua musica e i suoi testi, la rende quasi una forza vitale, un pozzo profondo in cui sprofondare e da cui riemergere tutte le volte che ne sentiamo il bisogno, senza per questo sentirci troppo in colpa. E se è vero che, come dice Troisi durante un’intervista di Gianni Minà insieme a Pino Daniele, la sofferenza in amore è un vuoto a perdere, da cui solo i cantautori guadagnano qualcosa, allora questo vale soprattutto per le canzoni di Truppi, che riescono a farci sentire meno soli la domenica ma anche tutti gli altri giorni. Per come scavano nei nostri sentimenti, perché ci fanno capire che non c’è niente di male nella nostra tristezza e che non siamo strani se continuiamo tanto a desiderare qualcosa che non riusciamo mai ad afferrare senza capire poi veramente di che cosa si tratti, come il suo testo Cercavo la felicità esprime magnificamente. E forse è proprio per questo che la domenica è il giorno che più somiglia al mondo poetico di Truppi, a questo senso di finitezza che pervade le cose più belle. È per questo che molto spesso la domenica si finisce per litigare? Perché non sappiamo fare i conti con quello che finisce? Ed è la strofa di chiusura di Domenica a ricordarcelo:
Ma qui si tratta solo di ingannare il tempo
Tanto alla fine si va a finire sempre
Che la domenica la gente litiga

Daniele Parisi, invece, ha letto alcuni suoi testi dal respiro calviniano, che ci riportano alle atmosfere de Gli amori difficili, per quel modo leggero – lì dove Calvino con leggerezza intende planare sulle cose dall’alto – di raccontare le incomprensioni, i non detti, le ossessioni, le paure di chi vive una relazione amorosa e lo fa intensamente. E così procede Parisi, isolando un elemento, portandolo all’esasperazione, esattamente come fanno gli innamorati. Emblema di quest’ironia è il racconto che Parisi fa di un uomo che dopo la fine della sua storia d’amore decide di buttarsi dall’aereo ma mentre precipita riceve un messaggio di lei che forse ci ha ripensato e che quindi forse… Ma lui non fa in tempo a finire di leggerlo che si è già schiantato a terra. Sulla stessa scia si inserisce il pezzo comico insieme a Gioia Salvatori. Qui siamo di fronte a una coppia che decide di congedarsi in modo alquanto originale: cenando per l’ultima volta insieme all’aeroporto finendo, però, ancora una volta per litigare con il sottofondo gli annunci dei voli che stanno per partire, voli che li porteranno definitivamente a destinazioni diverse.
Alla fine dell’incontro, nel salutare il pubblico, Gioia Salvatori ha confidato quanto questi appuntamenti, a cui hanno preso parte altri ospiti (tra cui Ilaria Gaspari, Barbara Chicciarelli, Valerio Aprea, Cristina Pellegrino etc), le abbiano fatto bene e quanto ne avesse bisogno. E come darle torto. Alla fine, ci si sente meno soli e meno tristi proprio come dopo aver ascoltato un brano di Truppi.