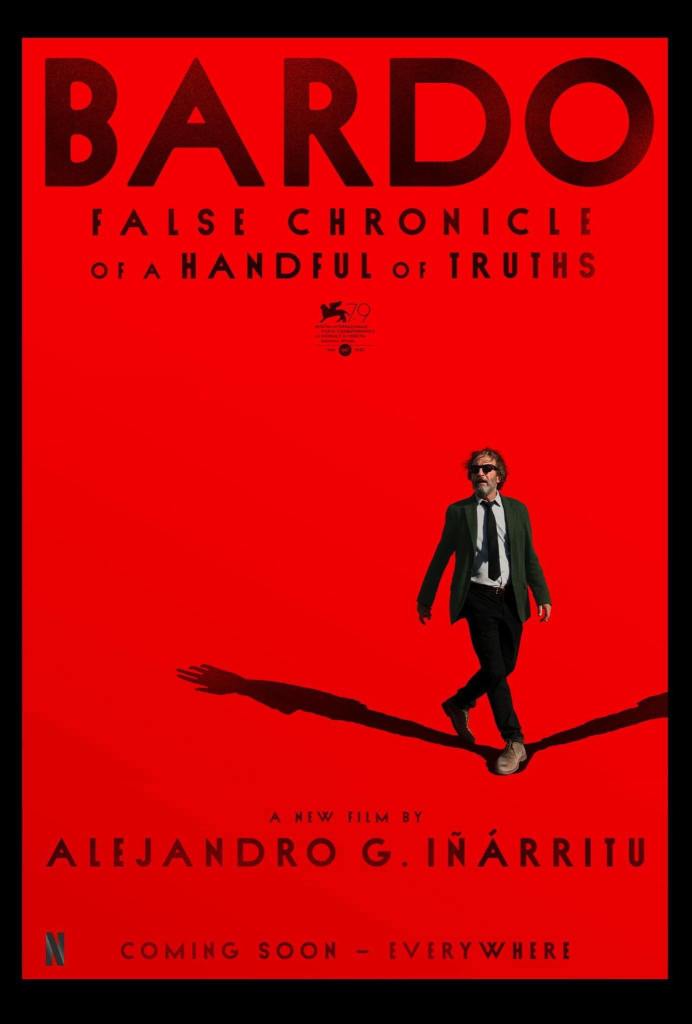Un caldissimo pomeriggio d’estate di pochi anni fa – ante Covid, la pandemia che ha tracciato un baratro tra ogni prima e questo poi – a San Luigi dei Francesi, à la Procure, ho incontrato una elegantissima signora che, mi disse l’amica che me la presentò, era la migliore amica di Jane Birkin. Ricevetti tutti i riferimenti utili per ricontattarla e spuntare un giorno e un’ora per un incontro con Lady Jane, “Sarà difficile strapparle una data, Jane non sta bene, ha diradato le uscite pubbliche, quando accetta lo fa solo per far contenta Charlotte”: ne sapeva zero, Charlotte, nel mio caso. Poco tempo prima, avevo rischiato di imboscarmi nel tempio in cui la ragazza è nata e ha trascorso l’infanzia, ninfetta dei genitori divi, del padre musicista poeta regista e pittore. Pochi lo sanno: Serge Gainsbourg, nato Lucien (“un nome da parrucchiere!”), faceva “cover” perfette dei pittori impressionisti, ma poi, imitando suo padre (transfuga russo a Parigi con la madre Olia: i Ginsburg da Odessa, in fuga dall’antisemitismo stalinista), prese a suonare nei locali: pianista di pianobar a Parigi, nel coeur-coeur della città tutta-luci, lui che provenuva dal 16°.
Il tempio è al 5bis di Rue de Verneuil, 7° arrondissement, Carré des Antiquaires: ora luogo di pellegrinaggio ma dal 1968 al 1991 residenza attiva e fervida del suo proprietario e designer, Serge Gainsbourg. È stato lui l’arredatore d’interni che ha voluto una cucina che è un salotto, con un pavimento che è una scacchiera, e un salotto che è un mausoleo e un museo. Vorrei parlarvi del cortile, dell’albero, e dei corridoi, ma non lo farò.
Vi parlerò dell’ingresso di Jane Birkin, convivente, in quelle stanze, dal ’68 all’80, di Serge Gainsbourg.
Vi parlerò di un duo irripetibile, della famigliola quasi-borghese cui Serge approdò con Jane, abbandonando il primo matrimonio da cui stava per nascere la sua prima figlia.
Vi parlerò di due dettagli degni di attenzione: il nero alle pareti, e la gigantografia che domina in salotto.
Ritrae l’icona par excellence, BB (pronuncia: bébé – c’è da restarci a pensare!): Brigitte Bardot, la musa di Serge, cui l’antichansonnier, poeta del Gasogramme, ha dovuto rinunciare semplicemente perché il marito è piombato a Parigi per riprendersela e sottrarla a lui, al “Quasimodo saltimbanque”: è Gunter Sachs, fotografo tedesco poi svizzero, imperversatore di rotocalchi, playboy riccone che viveva in una torre a Sankt Moritz da cui sono passati molti artisti delle correnti avanguardie.
Potrei tagliar corto e dirvi del fragoroso cambio della guardia al fianco dell’infernale Serge. Ma c’è di più. Anzi vengo dritta al punto: come Jane Birkin si impossessa di questa scena, la personalizza e la porta con sé.

La prima opportunità di incontro tra Jane e Serge avviene grazie a Pierre Grimblat, regista, che vuole metter su il film Slogan. Jane Birkin è giovanissima, viaggia con Andrew, fratello fotografo che lavora con Kubrick: è un’allegra truppetta di britannici (Kubrick novello expatriate, dagli USA dove è nato torna nell’Europa dei suoi avi) che si espande in Europa nelle arti nel cinema nella moda in un’epoca in cui diventa proverbiale la cosiddetta swinging London – anche Antonioni ne rimane coinvolto, e la immortala nel suo Blow-Up (1966, adattamento dal racconto La bava del diavolo di Julio Cortàzar): tra gli interpreti, Jane Birkin, 20 anni.
Jane ha tutto per essere una star magnifica: è longilinea e aggraziata, una dea, viso innocente e malizioso, grandi occhi chiari, capelli corposi fluenti lisci e una frangetta sbarazzina che la fa molto gamine: Serge la vede e la teme. Subito. Cos’ha, Jane, in più, rispetto a BB? L’innocenza per cominciare, la freschezza di ragazza curiosa e inconsapevole per proseguire, la totale mancanza di fame e sete per finire.
Non cerca nulla, non vuole nulla, asseconda tutto, Jane Birkin da Chelsea, London (Hammersmith/Fulham).
Tutto ciò che arriva è un dono come può diventare una sciagura: si sta come d’autunno sugli alberi le foglie.

Sul set di Grimblat i duellanti, Jane e Serge, i due lead-roles di Slogan, guerreggiano da eleganti schermidori. È fuori dal set che cominciano i dolori: Serge è apertamente ostile all’attricetta inesperta che, ritiene, gli dà filo da torcere non certo per sapienza ma per acclarata inesperienza. Lui la mortifica in continuazione. Pierre Grimblat si trova non tanto a dover fare da paciere quanto a dover cercare di armonizzare i suoi protagonisti per una buona resa nel film: è disperato. Organizza incontri al vertice a cui uno/a dei due non si presenta, o l’altro/a si siede ma subito dopo s’alza e se ne va, sdegnato lui tremante lei.
Cosa sta davvero accadendo? Serge è intimidito. Dentro di sé sa che lei gli piace. Anzi la vuole.
Però, no! Macché! Come venirne a capo? Non sa più come si fa? Fino a questo punto l’ha bruciato BB?
Molti dicono, Serge Gainsbourg è orrendo, è terribile, repellente.
Errore ingenuo di valutazione. È vero: ha occhi da rospo (così lo dipingevano, così ride Jane di lui in un gioco tra loro, tutto d’amore), ha orecchie a sventola che lui copre sotto una capigliatura ordinatamente disordinata, ha un naso gobbuto e storto, labbroni a volte secchi spellati che schiudono un sorriso ambiguo. Giovan Battista Basile avrebbe saputo imbastire attorno a lui una favola nera delle sue. Ma siamo (!) in una favola: la bellissima Jane ama Serge il rospo (ma quale rospo? –via!), lo ama profondamente.
Serge ha una presenza pazzesca. È un dominatore degli spazi. Impossibile non avvertire la sua malia. Jane la sente già nelle prime rovinose schermaglie dentro e fuori dal set, con Pierre Grimblat che prova a farli almeno conoscere come partner in Slogan: Serge aveva chiesto Marisa Berenson per il ruolo femminile (lui firmerà la colonna sonora), Grimblat ha preferito Jane Birkin, poco più di 20 anni, e Blow-Up già all’attivo.
Un altro minuscolo dettaglio. Jane proviene dal matrimonio, a Londra, col musicista John Barry, autore di colonne sonore (per i film su James Bond ma anche per Nata libera, poco dopo autore di The Persuaders – per la serie TV Attenti a quei due, e La mia Africa, e Balla coi lupi – 5 premi Oscar, prima e dopo Jane).
Jane, con lui, era passata direttamente dal collegio al matrimonio, da cui è nata la magica Kate, fotografa.
Oggi molto si parla del panier en osier che Jane aveva sempre con sé: ebbene in quei giorni di periglioso assortimento con Serge sul set sotto gli occhi sgranati di Pierre Grimblat quell’oggetto di moda è stato un insostituibile mediatore, quasi chiave ed emblema dell’amore che a un certo punto, a lungo atteso, scoppia.
Cosa cambia? Cosa interviene magicamente? Niente, assolutamente niente. Rien de rien du tout!
Grimblat li convoca a cena: cena di lavoro, n’est-ce pas? Ah ouais, bien sûr! Ma Grimblat non ci va. Li fa trovare in un ristorante di lusso l’uno contro l’altra seduti in un tête-à-tête incandescente (altro che lume di candela!), e lui li osserva non visto: insomma li ha cucinati. Tutto cambia mentre nulla in apparenza è cambiato. L’atmosfera, l’ambiente, la circostanza.
Serge non si sottrae al mestiere: si attiva in lui la funzione del seduttore, bè, in realtà, del gentiluomo galante. Dolce, delicato, elegante, attento: è fatta, Jane lo ha stanato, ha saputo risvegliare in lui la sua parte migliore, è riuscita a infrangere la corazza dello scorbutico dietro cui Serge nascondeva le sue insicurezze, il terrore di essere per sempre sconfitto dalla propria bruttezza di cui è, a dispetto di tutto, profondamente consapevole, e da cui cerca da sempre di riscattarsi mettendosi in scena (lo credereste?, ecco come accade, ecco come chi pubblicamente si cimenta nelle arti vince la propria debolezza: esponendosi – è il principio di contraddizione).
Jane di sé non ha modificato una virgola, è uguale a sé stessa: lui ha avuto un letterale capovolgimento. Chi è, dei due, il punto fermo? Chi dei due è adattabile e perseverante? Chi dei due non ha battuto ciglio?
E questo è stato solo l’inizio. Che ha avuto uno sviluppo, e una fine.

Chi dei due è passato nella bufera senza lasciarsi travolgere, anzi restando tenacemente in piedi? Esemplare ciò che accade nel primo anno more uxorio: Jane è chiamata nel cast di La piscine, vi imperversano Alain Delon e Romy Schneider. Serge impazzisce. Tornano tutti i suoi fantasmi, l’assale l’angoscia! Alain Delon! Figuriamoci, sedurrà Jane, gliela porterà via! Jane è la sua compagna ma non sua moglie, non ancora madre di Charlotte, il film si gira in Costa Azzurra, dove Delon si presenta con una decappottabile e il suo fare da despota sentimentale: è temuto perché pare conquisti le sue partner sul set come un algido collezionista, ma forse è solo la sua fama presso gli uomini appunto che lo temono come concorrente. Come Serge l’insicuro.
La magia (nera?) del set non altera alcun equilibrio, sorvegliata da presso dall’intera famiglia Gainsbourg, trasferita in Costa Azzurra per unire l’utile (lavoro per Jane) al dilettevole (vacanze al mare per tutti loro).
Jane Birkin è la compagna di Serge Gainsbourg, ha tenuto con sé la piccola Kate, poi genererà Charlotte, ha tenuto con sé la cagnolina Nana, bull-terrier inglese, e la ragazza alla pari che la aiuta con le bambine: Jane ha colonizzato la tana del burbero Serge, il suo hôtel particulier au 5bis, Rue de Verneuil, 75007, Carré des Antiquaires, au coeur-coeur de la ville lumière: buco nero in cui Serge s’era nascosto con la gigantografia–feticcio di BB, un antro oscuro (come i mostri, si percepiva mostruoso) nemico della luce, impenetrabile.
Si aprono tutte le porte e le finestre, circola aria, persino il cortile viene incluso nei locali usati della dimora. E poi Jane è la musa di Serge. Non una musa di passaggio come France Gall e Anna Karina o la stessa BB. È Jane l’interprete in carne e ossa di un’idea di erotismo e ribellione alle convenzioni, di rivoluzione allegra, di cui Jane non è semplice recettrice ma creatrice compartecipe, intendiamoci bene. Melody Nelson o la bella di Je t’aime moi, non plus non è un oggetto femminile ma la protagonista di una liberazione sessuale, di chiara matrice artistica e provocatoria, in cui Jane e Serge sono solidali, e che coinvolge presto anche Charlotte.
Una liberazione femminile attraverso il cinema la musica la fotografia (grazie a Andrew Birkin, fratello, ma anche grazie all’incontro, all’inizio del loro periodo d’oro, col fotografo e amico Tony Frank): propensione allo scandalo, si griderà, e sappiamo quanto grida gride e gridi siano ambigui. Propensione al sarcasmo, ecco l’apporto decisamente ingombrante di Serge à la cause comme à la cause, à la guerre comme à la guerre – anche sulla scorta della programmatica guerra alla melensa canzone degli chansonniers, in linea con Boris Vian (e a ritroso, con Céline), a favore di esistenzialismo e relativa chanson incarnata da (Belfagor) Gréco: Serge faceva pochi passi sullo stesso lato del suo 5bis e entrava al numero 33, saliva in casa di Juliette Gréco e insieme cantavano e componevano: scrisse per lei La Javanaise) – ci ho abitato al 33, e all’8, juste en face au 5bis!
Jane dopotutto era con lui in sintonia perfetta, però con tempra britannica, col suo understatement, cui si sommavano grazia, bellezza, innocenza, malizia da adolescente eterna.
E piena cittadinanza francese, vorrei dire, fin nelle fibre, per la giovane inglese in linea col tipo femminile di Twiggy e Veruschka o Françoise Hardy, che però non salvò il legame con Serge Gainsbourg da un lento e prevedibile naufragio segnato da La Décadanse (1971), elucubrazione edonistica in cui l’erotismo è ritratto, cioè anche accorciato, in una serie di perentorie, godute istruzioni.
La favola finisce. Ciascuno per la propria strada. Verso nuovi assortimenti. Nuova prole. Nuova musica.
Per Jane, nuovi film, e alcuni libri: Post-Scriptum. Diario 1982-2013, sulla liason con Serge Gainsbourg, Munkey Diaries (2019, Clichy), periodo 1957-1982. Non dovrei dirvelo, ma per conoscerli bene, Jane e Serge, dovreste vedere Jane by Charlotte, docu-film del 2021, omaggio da figlia a madre, e leggere: 5BIS RUE DE VERNEUIL, di Marie David (documentarista), Plon 2020, che vorrei tradurre per qualche sbadato e non abbastanza affamato/assetato editore italiano, magari lo stesso che pubblica BHL a tappeto.
Non credo, diversamente da BB, Serge abbia mai rinunciato a Jane, al fatto che lei era il suo personaggio letterario, la sua Lady Jane poetica. No, non l’ha dimenticata: lui che correggeva il caffè, buttava bicchierini giù che era una continuazione e fumava come respirava, sulla distanza ne è morto.