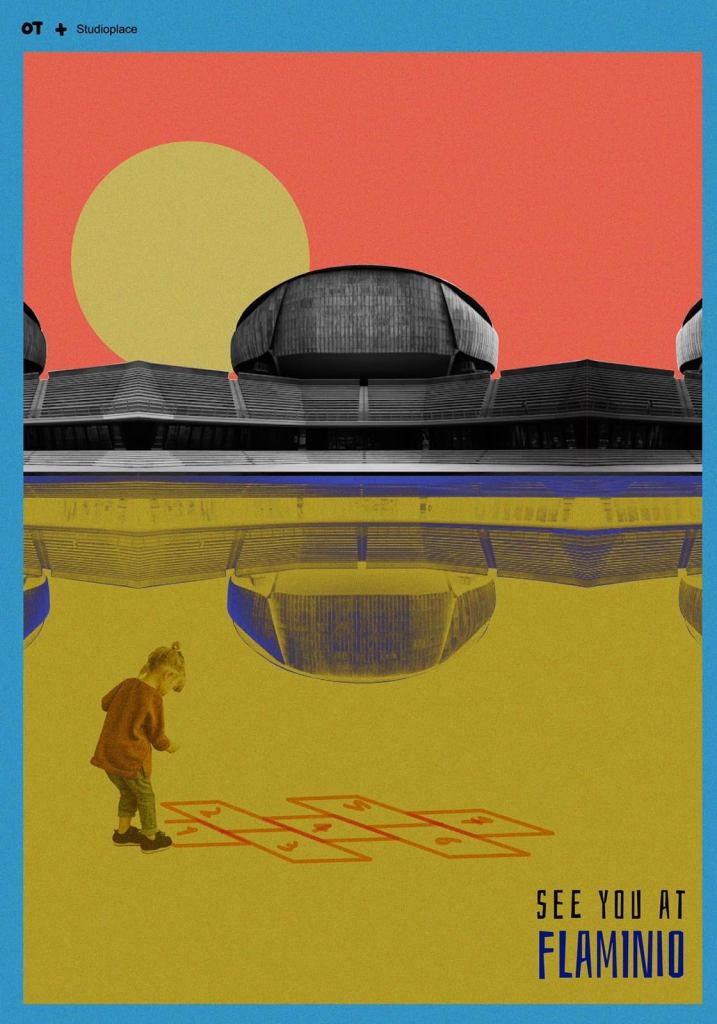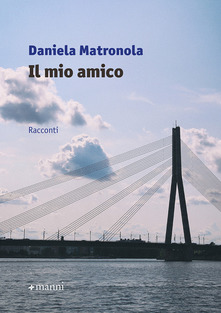Intimo e personale come una pagina di diario, il film Molecole è una lettera scritta dalla mano di Andrea Segre, indirizzata al padre Ulderico, e a Venezia, città di origine della sua famiglia. La pellicola è stata presentata come film di pre-apertura alla 77esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia.
Andrea Segre, documentarista nato nel veneziano – più precisamente a Dolo – ma romano di adozione, nel febbraio del 2020 coglie l’occasione del lockdown per immergersi in un processo di ricerca sulle radici della propria famiglia. Le norme di distanziamento sociale però “bloccano” Venezia. Il momento si rivela così l’occasione giusta per indagarne il passato. Per questo, il documentario non è un opera programmata, ma è un prodotto nuovo, diverso, figlio di un periodo «in cui il tempo si è annullato, e lo spazio sospeso». Come dichiara lo stesso regista: «Molecole è sgorgato. Come l’acqua».

Per rendere tale processo più realistico, Segre decide di ripercorrere alcune tappe fondamentali: i luoghi di Venezia preferiti del padre, scomparso nel 2008, che erano stati prontamente immortalati in brevi video d’epoca girati in formato super8. Piazza San Marco, Santa Maria della Salute, Punta della Dogana, Giudecca. I video del regista così si sovrappongono alle memorie del padre, in un tentativo di collage cinematografico e sentimentale, immortalato dalla fotografia di Matteo Calore. Ma come il caìgo della laguna, sono ancora numerosi i punti foschi di questa figura paterna così significativa e allo stesso tempo sfuggente.
Per rimettere in ordine i pensieri del passato e del presente, Segre si serve di un metodo empirico, un’osservazione dal vero della città, che fin dal suo titolo rende omaggio alla formazione scientifica del padre. Ulderico Segre è stato uno stimato docente all’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, ordinario di Chimica presso la facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.

Per questo, il titolo Molecole è segno prima di tutto di una metodologia che spinge il regista a guardare la città con occhi nuovi. Le molecole rimandano alla necessità di un’osservazione «della materia di cui tutti siamo fatti, ma che non possiamo vedere». Segre interpreta il movimento delle cose come un’associazione di elettroni, che è alla base di qualsiasi principio di vita e che porta inevitabilmente a un contatto, a una contaminazione.
La parola “contaminazione” non è utilizzata per caso in un documentario che è il primo dei tanti che saranno realizzati su questo inedito momento storico che stiamo vivendo. Il famigerato lockdown culla la riflessione di Segre, che si ritrova da solo, accompagnato dalle musiche di Teho Teardo, a vagare per le calli di una città irriconoscibile, cristallizzata in un controverso limbo tra la vita di una laguna che si riscopre libera e la morte di una crisi economica inesorabile.
Le alluvioni del 12 novembre 2019, la pandemia mondiale, il carnevale cancellato, i danni inferti dal traffico delle grandi navi: sono numerose le sfide che il mondo contemporaneo ha imposto a Venezia, che prima di essere città è un articolato arcipelago, una delle ultime roccaforti di una bellezza dal sapore antico che ha colto l’occasione della quarantena per interrogarsi sui trascorsi di una vita pre-pandemia in cui qualcosa del passato è chiaramente irrisolto.
Oltre a Piazza San Marco e al Ponte di Rialto, Segre ci accompagna alla scoperta dei confini della città. A Sant’Erasmo, per esempio, i danni causati all’ecosistema modificano i cicli della maree, facendo sparire le caratteristiche barene, ovvero le lingue di terra che costellano la laguna e che cambiano colore a seconda della stagione.

Le acque limpide, il silenzio della sera, il riaffermarsi della natura. Allora è così che dovrebbe essere Venezia?
Difficile rispondere a tale domanda, quando il centro della città ormai abbandonato si costella di vetrine vuote e attività chiuse, strascichi di una crisi sanitaria, ma prima di tutto sociale ed economica.
Segre alterna alla cronaca dell’acqua alta un momento di eccezionale bassa marea che, attraverso le riprese del regista, disvela le fragili fondamenta sui cui si fonda la città. Di sicuro, l’incertezza su cui poggia oggi Venezia non riguarda solo la laguna, ma è un monito di stampo universale, cartina di tornasole che riguarda tutte le nostre città, oggi messe in pericolo dalle tragiche conseguenze di un cambiamento climatico che imperversa e un interesse economico sempre più invasivo. Forse che la pandemia abbia solo rivelato la dolente solitudine di cui le nostre città erano già affette?

In questo caso l’isolamento della città si unisce a quello più intimo e personale del regista, entrambi orfani di presenze umane: «Cosa resta della vita quando intorno hai solo acqua e vapore freddo? Cosa puoi vedere nell’invisibile?».
A fare eco al senso di smarrimento del regista, è la testimonianza di Elena Almansi, 24 anni, vogatrice, figlia di vogatori, una dei pochi veneziani che non sono migrati in terraferma. «Della mia classe delle elementari siamo rimasti qui solo in cinque o sei» racconta. Allora, perché restare?
La risposta si offre agli occhi di Elena ogni giorno, quando nella solitudine della sera si riappropria del Canal Grande, varcando l’imponente Ponte di Rialto, fino a raggiungere il Ponte delle Guglie. La sontuosità delle facciate dei palazzi veneziani si accompagna alla lettura de Lo straniero di Albert Camus, che, come lo studio delle molecole, aiuta Segre a far luce sul complesso rapporto tra l’uomo e il suo inevitabile destino.

Nel silenzio più spettrale Segre incontra i pochi esseri umani che tengono oggi Venezia in vita. Nonostante gli effetti di una condizione fortemente precaria, Venezia è anche una storia di resilienza e di resistenza. Nel finale, il compleanno festeggiato via Zoom di una bambina lancia un monito di speranza, il sogno di un futuro migliore. Saranno infatti le nuove generazioni le prime eredi di una città che sta probabilmente entrando in una nuova fase della sua storia. Forza e debolezza non sono opposti per Venezia, ma impareranno a convivere, simbolo di una costante ricerca di equilibrio tra l’essere umano e la Natura, che è anche la paura di tutto ciò che è per noi inevitabile.