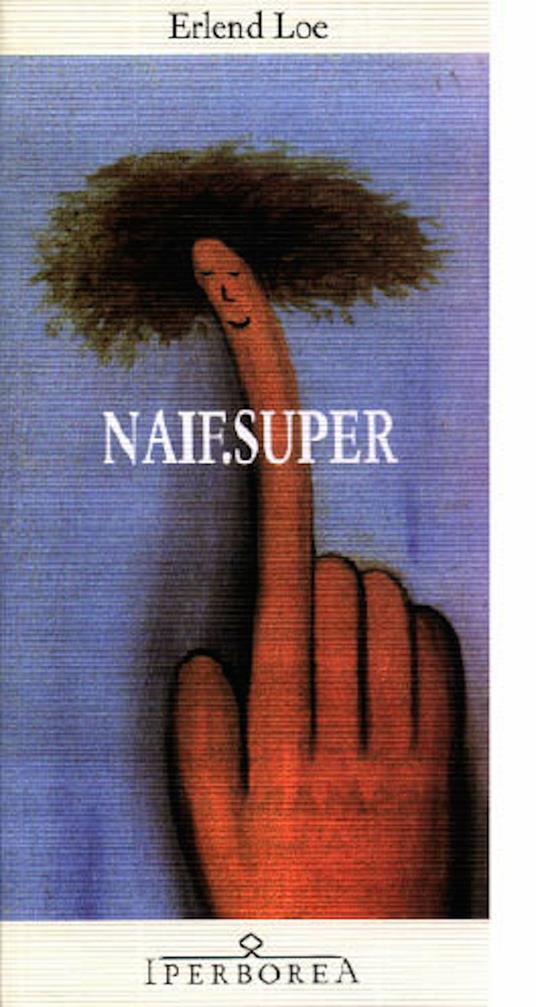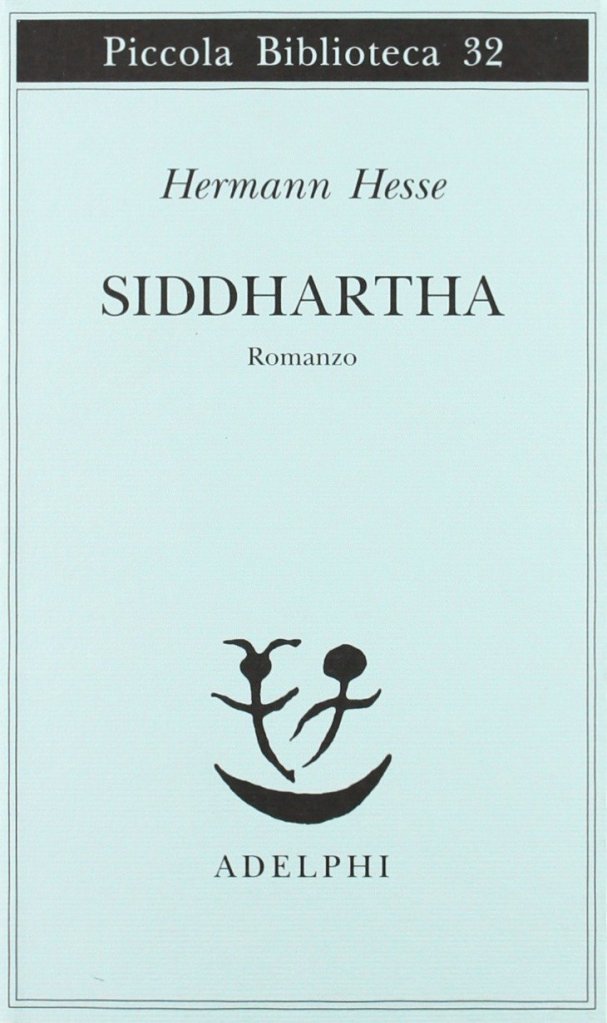È passato più di un anno da quando ho iniziato ad abbozzare questo testo: ero appena arrivata a Napoli, più disorientata di quanto credessi. Persa tra le strade della città e le possibili vie della mia vita, ho provato a tradurre in scrittura questo flusso confusionario di pensieri che, almeno fino a ieri, non ero più riuscita a mettere in ordine.
Dopo un pomeriggio piuttosto pesante al lavoro, sono andata al cinema con l’intenzione di vedere Licorice Pizza, ma il film non era in programma e così sono finita nella minuscola sala in cui proiettavano La figlia oscura di Maggie Gyllenhaal – tratto dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante –, del quale ero comunque in attesa.
Uscita dal cinema, ancora trafitta dal film, mi è arrivata la notizia della morte di Letizia Battaglia.
Ho capito allora che era giunto il momento di rimettere mano a questi cocci di pensieri sparsi e, allo stesso tempo, connessi.
1. Smarginare attraverso lo sguardo

È in questa immagine che le figure di Letizia Battaglia ed Elena Ferrante si incrociano e sovrappongono inconsapevolmente, costrette dalla mia necessità di creare relazioni, dando un volto ai personaggi dei libri e una storia alle persone immortalate nelle fotografie. Capelli un po’ arruffati dall’aria di mare e dalla polvere sollevata nel giocare per strada, sguardo penetrante e interrogativo – quasi inquisitore –, espressione corrucciata: sono questi i dettagli che mi erano rimasti impressi de La bambina con il pallone e che hanno fatto ri-emergere dagli abissi della mia scarsa memoria questa fotografia mentre leggevo le descrizioni di Lila ne L’amica geniale.
«Era arruffata, sporca, alle ginocchia e ai gomiti aveva sempre croste di ferite che non facevano mai in tempo a risanare. Gli occhi grandi e vivissimi sapevano diventare fessure dietro cui, prima di ogni risposta brillante, c’era uno sguardo che pareva non solo poco infantile, ma forse non umano».
La miccia di questa connessione è stato lo sguardo: uno sguardo che è uguale e diverso allo stesso tempo, che racconta un dolore che è intimo e comune. È uno sguardo «forse non umano» che catalizza, che si rende finestra su vite parallele destinate a intersecarsi.
La storia di Lila, della bambina col pallone e delle tante altre protagoniste (o possibili tali) dei ritratti di Ferrante e di Battaglia è la storia, infatti, di soggettività appartenenti a mondi, luoghi e tempi differenti, accomunate però dalla subalternità che caratterizza il loro essere «donne, più o meno giovani, ritratte nella relazione con le molteplici oppressioni agite dal dominio patriarcale», come scrive Isabella Pinto nel suo libro Elena Ferrante. Poetiche e politiche della soggettività, riprendendo la stessa autrice.
È in questa rete di rimandi che racconto e fotografia si dissolvono, che la finzione della narrazione e i confini della fotografia si infrangono nella realtà, in una quotidianità fatta di violenza patriarcale e delle forme di resistenza e di lotta che le si oppongono.
È nel 1980 – anno in cui la fotografia viene scattata – che Lila per la prima volta ha chiaro il concetto di smarginatura e cerca di spiegarlo a Lenù.
«[…] Questa sensazione si era accompagnata a una nausea e lei aveva avuto l’impressione che qualcosa di assolutamente materiale, presente intorno a lei e intorno a tutti e a tutto da sempre, ma senza che si riuscisse a percepirlo, stesse spezzando i contorni di persone e cose rilevandosi. […] Nell’occasione in cui mi fece quel racconto, Lila disse anche che la cosa che chiamava smarginatura, pur essendole arrivata addosso in modo chiaro solo in quell’occasione, non le era del tutto nuova. Per esempio, aveva già avuto spesso la sensazione di trasferirsi per poche frazioni di secondo in una persona o in una cosa o un numero o una sillaba, violandone i contorni. […] Ma quella notte di Capodanno le era accaduto per la prima volta di avvertire entità sconosciute che spezzavano il profilo del mondo e ne mostravano la natura spaventosa. Questo l’aveva sconvolta».
La natura spaventosa del mondo, fatto di brutture e violenze, si palesa anche a Eugenia – bambina che ricorda quelle ritratte da Battaglia o Ferrante –, protagonista del racconto Un paio di occhiali, che apre la raccolta Il mare non bagna Napoli di Anna Maria Ortese.
Quando Eugenia finalmente indossa il suo primo paio di occhiali e riesce a mettere a fuoco il mondo attorno a sé, la reazione non è di entusiasmo: vedere il mondo in maniera più nitida significa rendersi conto che, in realtà, non è poi così bello.
Significa individuare le relazioni di potere e le linee di oppressione che caratterizzano la nostra società, svelandone l’impalcatura gerarchica e la sostanza di privilegi e soprusi.
Ed è proprio perché viviamo in un mondo che crolla a pezzi, in cui noi stessi siamo a pezzi, che è fondamentale riconoscersi e allearsi, unirsi per essere quantomeno dei pezzi uniti anziché sparsi.
2. Riconoscersi e abitarsi
«Ancora non mi sono chiari i nostri rapporti. So che certe immagini del mio passato sono entrate nei suoi sogni; che posso scacciare la sua paura opponendole la mia resistenza. So che abito il suo sangue e la linfa dell’albero, ma sento che non mi è concesso di cambiare la sua sostanza, né di usurparle la vita. Lei deve vivere la sua vita; io sono soltanto l’eco di un sangue che appartiene anche a lei»
Gioconda Belli, La donna abitata
La bambina con il pallone vede ritratta una di quelle numerose bambine immortalate da Battaglia, nelle quali la fotografa si rivede e nelle quali rivive.
«Le bambine sono io a cercarle, con molta emozione: quando incontro la ragazzina imbronciata, sulla soglia dell’adolescenza, magra con le occhiaie, i capelli lisci, sono io. E quando la fotografo è come se facessi un incontro di bambina con bambina».
Battaglia, tramite la fotografia, dissolve i confini che separano la sua pelle dal resto del mondo, raccontando una realtà a cui appartiene e rappresentando una pluralità di volti, una polifonia di vissuti e resistenze, di soggettività ai margini della società, delle città e dei quartieri.
«Amo fotografare le donne perché sono solidale: devono ancora superare tanti ostacoli verso la felicità, in questa società maschilista che le vuole eternamente giovani, belle, con una concezione dell’amore che spesso, in realtà, è solo possesso. E cerco gli occhi profondi e sognanti delle bambine: mi ricordano me stessa a dieci anni, quando mi resi conto, di colpo, che il mondo non era poi così bello. Ecco perché le bimbe che ritraggo non ridono mai: le voglio serie nei confronti del mondo, come lo sono stata io».
Ogni vita è in realtà l’intreccio di storie differenti, è l’affermazione di sé attraverso la dissoluzione dei propri confini e l’abitazione con altri vissuti passati e presenti.
3. Gomitoli di relazioni e affetti
Amiche o Le amiche geniali?
La realtà ritratta da Battaglia e Ferrante è una quotidianità fatta di relazioni e amicizie, di rapporti che permettono di riconoscersi nelle differenze e, attraverso queste, resistere, crescere e arricchirsi.
Non si tratta di relazioni di tipo speculare, ma di rapporti che innestano un processo di reciproco riconoscimento e vicendevole influenza, di legami che si alimentano e vivono in maniera vorace, insaziabile di vita, di conoscenza, di metamorfosi.
Accade a Lila e Lenù, come anche accade a Laura e Alina, le amiche de La figlia unica di Guadalupe Nettel: nell’altra ci si (ri)conosce e nell’assenza dell’altra una parte di noi si perde, creando un vuoto non altrimenti colmabile.
«Quanto più amiamo una persona, tanto più fragili, più insicuri ci sentiamo a causa sua. Ho capito quanto fosse importante la presenza di Alina nella mia vita. Esistono esseri senza i quali non ci si può concepire in questo mondo. E per me Alina era uno di quelli. Se fosse scomparsa, una parte di me se ne sarebbe andata con lei».
4. Strumenti per riprendersi «il mondo ovunque sia»
Per Letizia Battaglia il bianco e nero è lo strumento che permette di raccontare la realtà in tutta la sua intensità e complessità, elementi che i colori rischierebbero di far sbiadire, non permettendo di cogliere le sfumature, le luci e le ombre, la particolarità dei luoghi, delle cose, delle persone.
È una realtà che Battaglia è in grado di raccontare perché da lei stessa incarnata, perché abitata dalle persone da lei ritratte.
Per Elena Ferrante esistono prospettive diverse, i vissuti di bambine, di donne, di soggettività spesso taciute, di «personalità diasporiche» che – come scrive Pinto – «abitano, costruiscono e raccontano temporalità postumane».
Esiste un altro tipo di sguardo, imprevisto e posizionato, che irrompe nella narrazione dominante e ne infrange le regole, creando spazi inediti, raccontando immaginari impensati e storie nuove.
Esistono, infatti, infinite storie dentro la Storia, esiste un’irriducibile pluralità di soggetti, di forme di vita e di relazioni, esistono bisogni e desideri inascoltati e, allo stesso tempo, sovversivi.
Esiste la storia di una bambina nata e cresciuta in un rione povero di Napoli, esiste la storia di una bambina che vive e gioca tra le strade di Palermo, esistono innumerevoli storie di bambine che corrono tra le vie di tante altre città del Sud.
Abitare i margini, adottare uno sguardo attraverso il quale riconoscersi e creare connessioni sovversive, tessere relazioni di amore e di lotta.
Fuoriuscire dalla norma, raccontare un’altra storia.
Letizia Battaglia: il nome di quella che è stata una grande fotografa, forse il nome che potrebbe avere ognuna delle bambine da lei ritratte.
L’immagine di copertina è di Letizia Battaglia.